 |
 |
 |
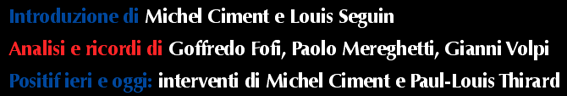 |
ROGER TAILLEUR NEL SUO TEMPO
di Michel Ciment, Louis Seguin
Il percorso critico di Roger Tailleur è relativamente breve. Si estende su vent’anni appena, dai primi anni Cinquanta alla fine degli anni Sessanta, ma stupisce per la sua qualità. La maturità dei suoi testi è immediata. Nulla in lui che porti tracce di esitazioni, di eccessi, di goffaggine, di rifiuti o compiacenze umorali. Quella lucidità, quella pertinenza sono tanto più notevoli perché ha cominciato a scrivere e poi ha deciso di abbandonare la critica in epoche di transizione che non predisponevano alla chiarezza, ma invitavano piuttosto alla veemenza e alla verticalità del partito preso.
Nel 1950, quando manda un articolo su Nodo alla gola a La Nouvelle République, poi nel 1952, quando con degli amici fonda e anima i sette numeri ciclostilati di Séquences, e quasi nello stesso tempo quando, su invito di Bernard Chardère, comincia a collaborare al giovane Positif, le carte della critica, in Francia, sono lontane dall’essere distribuite. Gli scritti di Roger Tailleur mal si conciliano con la vulgata contemporanea per cui tutto ciò che di notevole è stato scritto sul cinema in Francia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è passato per la sola strada maestra che va dalla Cinémathèque alla Nouvelle Vague, via Cahiers du Cinéma. La situazione era nello stesso tempo più ricca e più complessa. La fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta hanno visto sbocciare un bouquet di esperienze, fitto di incroci di paesi e di film, ma anche di sale e di scritti.
Roger Tailleur ha dodici anni quando la guerra scoppia. Ha già frequentato le sale di Bordeaux e della sua regione, molte delle quali appartenevano all’autore più completo (sceneggiatore, regista, produttore, proprietario di studi e di sale) del cinema francese, quale fu Emile Couzinet. Per fortuna, il cineasta di Trois marins dans un couvent non programmava solo i suoi film. È lì che Roger Tailleur ha scoperto, incantato, alla vigilia della guerra e soprattutto nel dopoguerra, il cinema americano. Nel 1952, ospite al sanatorio per studenti di Saint-Hilaire-du-Touvet, diventa responsabile del cineclub che era affiliato alla Fédération Française des Cinéclubs, movimento allora al massimo della sua diffusione. Al suo arrivo a Parigi, fine 1953, frequenta, naturalmente, la leggendaria sala di Avenue de Messine, poi il Musée Pédagogique e, dieci anni dopo, il Palais de Chaillot. Bazzicò anche le sale che, da Rue Troyon a Avenue de l’Opéra, passando per Rue Duphot, accolsero l’una dopo l’altra un unico cinema d’art e d’essai. Si avventurò anche in posti marginali quali erano Les Agriculteurs, La Pagode, Le Panthéon, lo Studio-Bertrand o lo Studio des Ursulines, ma la sua passione lo portava, innanzitutto, altrove. Non mancò mai a uno spettacolo delle sale che davano in seconda visione, dunque più a buon prezzo, i film americani in versione originale, cioè tanto Le Mac-Mahon quanto Le Napoléon, Le Cinéac Ternes, L’Artistic, Les Reflets, il Cinémonde Opéra o lo Studio-Raspail.
Bisogna aprire una parentesi su due sale che non aprivano le porte solo ai film (principalmente americani, ma anche italiani) in VO ma che, una volta alla settimana, accoglievano dibattiti in cui si ritrovavano i “giovani” critici dell’epoca. Una di esse, il Cardinet, ebbe una vita effimera, ma l’altra ebbe una fortuna ben più lunga. Le Studio-Parnasse era, quando Roger Tailleur cominciò a frequentarlo, animato, ormai da alcuni anni, da un uomo la cui influenza, benché di natura differente, fu almeno pari all’intervento di Henri Langlois.
Al contrario del Maestro della Cinémathèque, Jean-Louis Chéray, il cui nome è oggi ingiustamente dimenticato, non solo costruiva programmi di valore e sorprendenti, ma discuteva a voce con i suoi spettatori. In più, c’era un registro in cui ciascuno poteva esprimere opinioni e porre domande a cui egli rispondeva con attenta regolarità. Soprattutto, organizzava, dopo lo spettacolo del martedì sera, prima di cambiare programma all’indomani, dei dibattiti cui partecipavano e si contrapponevano, da una parte, Robert Benayoun, Albert Bolduc, Jacques Demeure, Gorge Goldfayn, Ado Kyrou, Luois Seguin o Paul-Louis Thirard e, dall’altra, André Bazin, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Luc Moullet, Jacques Rivette, Eric Rohmer o François Truffaut. La controversia era spesso al calor bianco, persino aggressiva, e le argomentazioni, che si trattasse di Neve rossa, di Sentieri selvaggi, di La regina d’Africa o di Pietà per i giusti, perentorie, definitive. Tailleur ascoltava questi scontri verbali con interesse appassionato e, malgrado la sua timidezza, non disdegnava di intervenire, in generale a fianco del primo gruppo. È stato lì che si sono separate le scuole e sono maturati i giudizi le cui antinomie arricchirono Positif e i Cahiers du Cinéma.
Roger Tailleur aveva molto letto. Ma non di cinema, e in questo campo le sue letture non sempre erano conformi alla doxa cinematografica. Era stato assai più influenzato da certi settimanali che avevano nutrito i suoi sogni che non da periodici che del resto non raggiungevano le librerie bordolesi. Era stato un lettore assiduo non solo degli Ecran français di prima e dopo lo zdanovismo o del cattolicissimo Radio-Cinéma-Télévision (l’antenato del Télérama alla “moda” di oggi), ma anche e soprattutto di Cinémonde e Cinérevue, persino di Film complet e di Mon film. È su quelle pagine che gli piaceva sentir parlare dei film che aveva visto e soprattutto che voleva vedere, delle attrici che amava tout court e degli attori che ammirava. Così non prese conoscenza, se non tardi, alla biblioteca del sanatorio, della seconda serie di La Revue du Cinéma, diretta da Jean-Georges Auriol, degli articoli di Roger Leenhardt o André Bazin su Esprit e delle schede tecniche che pubblicava la rivista dell’UFOLEP: Image et Son. Ancor più a lungo, ignorò Saint-Cinéma-des-Prés, La Gazette du Cinéma e L’Age du Cinéma. L’accademismo dei primi numeri dei Cahiers du Cinéma non lo entusiasmò troppo. È anche vero che era prima dell’arrivo, cui nessun doveva restare indifferente, di Claude, François, Jacques, Jean-Luc e degli altri.
Sul cinema, non aveva letto che pochi libri. Nel 1949, si era comprato la prima edizione dell’Histoire di Georges Sadoul, in cui inverosimili e stalinisti giudizi non lo avevano esaltato. Aveva, per contro, come bibbia un’opera oggi dimenticata - e, bisogna riconoscerlo, obsoleta - ma che ha permesso a tanti di venire a conoscenza o di ritrovare una storia lontana dalle convenzioni. Era stata pubblicata nel 1947 da Colette d’Halluin, ed era l’Histoire du Cinéma Américain di Pierre Artis, discepolo del resto del celebre papa di Montauban, Hugues Panassié. Roger Tailleur conosceva bene anche due saggi pubblicati da André Bonne: Lo schermo demoniaco di Lotte Eisner e il Cinema dell’arte di Nino Frank. Aveva trovato insufficiente la brochure di André Bazin su Orson Welles, ma aveva salutato come era giusto, prefazione dello stesso Bazin compresa, la prima edizione, nel 1953, del Western di Jean-Louis Rieupeyrout. Considerava, poi, con una certa diffidenza le pagine, citate in tutte le buone sacrestie, di Le Cinéma-a-t-il une âme? di Henri Agel. Si trattava senza dubbio di una biblioteca minima, ma era compensata dalla conoscenza diretta e sicura di un gran numero di film e dalla curiosità di una passione insaziabile.
Tutta l’attività critica ebbe Positif come centro. Mai, al contrario di Raymond Borde o di Louis Seguin, si lasciò distrarre dalle Editions de l’Etoile. Eppure era uno dei pochi a essere apprezzato dai suoi avversari. Jean-Luc Godard e François Truffaut amavano quello che lui scriveva e ammiravano l’incisività della sua scrittura. L’ultimo gli propose anche di collaborare a Arts quando lui passò alla regia, e Jacques Doniol Valcroze lo fece entrare a France-Observateur da cui fu cacciato a vantaggio di Michel Cournot quando il settimanale si trasformò in Nouvel Observateur. Fu, come mostra la bibliografia, invitato a collaborare a parecchie altre testate. Ma restava ostinatamente fedele a una rivista dove contava, all’inizio, almeno su un amico, Louis Seguin, e dove se ne fece molti altri.
Questa costanza non comportava un’adesione senza riserve. Fu, per esempio, assai contrario all’articolo del numero 11, “Quelques réalisateurs trop admirés”, in cui si attaccavano alcuni cineasti che amava. La stessa cosa avveniva per la politica. L’ammiratore “democratico” di Franklin D. Roosevelt e di John Kennedy era profondamente liberal e seppe prendersi dei rischi non da poco, ma diffidava delle estreme. Sostenne Henri Langlois ma gli avvenimenti del maggio ’68 sorpresero sgradevolmente un uomo che, proveniente da un ambiente modesto, non aveva avuto la fortuna, malgrado le sue doti e il suo lavoro, di seguire degli studi regolari come i giovani ribelli che, a suo parere, facevano un po’ troppo facilmente tabula rasa della cultura del passato. In questo, la sua posizione non era lontana dalle celebri invettive di Pasolini, verso le quali era ben disposto. Questo disaccordo non ebbe un ruolo da poco nel suo allontanarsi dal cinema e dalla critica. Uno dei suoi ultimi testi polemici (non ne abusava) fu dedicato all’inedito zelo dei Cahiers du Cinéma che, nella loro parentesi maoista, bruciavano il cinema americano con lo stesso ardore con cui l’avevano adorato.
La sua separazione da Positif spiacque, ma nessuno gliene volle. In particolare, gli ultimi arrivati degli anni Sessanta - Michel Ciment, Bernard Cohn, Frédéric Vitoux - di cui aveva incoraggiato gli inizi, gli restarono assai vicini. Roger Tailleur consacrò gli ultimi anni della sua vita ai viaggi, alla pittura antica, alla sua famiglia e agli amici. Faceva ancora qualche incursione nelle sale cinematografiche per confrontare i suoi gusti con quelli della sua rivista preferita. E la malattia se lo portò via.
|
||
NOTA DEL CURATORE di Gianni Volpi Come dicono Ciment e Seguin nell’introduzione, l’opera critica di Roger Tailleur è tutta concentrata nell’arco di un ventennio scarso, ma le sue dimensioni sono tali da rendere difficile concentrarla in un solo volume. Ci è sembrato perciò utile, per avere un minimo di completezza sul lavoro di un critico di questa rilevanza, dividerne la “produzione” in due volumi. Il primo, questo, è dedicato ai suoi scritti su Positif, che è stato il perno della sua attività critica; il secondo, in uscita nel 2007, comprenderà i saggi lunghi e altri scritti. Degli scritti su Positif sono stati tradotti tutti i testi (diciamo il 95% di essi), tranne le “brevi” della rubrica “de A à Z” e quelle “occasionali” di poche righe su brutti film festivalieri, ma “necessarie” ai rendiconti dai festival che Positif voleva completi. In questa chiave possono essere viste anche certe note assai interne ai problemi e alle polemiche francesi di quegli anni, incomprensibili al lettore (tanto più se italiano, tanto più oggi, a distanza di tanto tempo) senza i testi cui si riferiscono o note e postille su fatti e circostanze e persone. Per quanto riguarda le “brevi”, molte delle osservazioni che contengono sono recuperate in schede più ampie, così è anche per le “note” che corrispondono a quel suo stile così peculiare di scrittura elegantissima eppure di “intervento” continuo, giorno per giorno, attento a tutto quanto capitava ed era pubblicato. Era davvero «uno dei rari critici a leggere i colleghi e a tenere conto, in senso favorevole o contrario, del loro parere». Era parte attiva, e ascoltata, del “dibattito” cinematografico. Su questo terreno relativo al cinema francese, ci è parso più utile pubblicare, accanto alle sue bellissime e ampie analisi di alcuni film-chiave degli anni Sessanta, un vero dibattito sulla Nouvelle Vague in cui tutti i temi relativi al cinema nazionale, dispersi qua e là in schedine più o meno brevi e occasionali, sono ripresi e sistematizzati (e confrontati con la visione degli altri redattori). Non ci è sembrato il caso di sacrificare oltre il lecito a una filologia maniacale, di arida e inutile erudizione che era quanto più odiava Roger Tailleur. Per la stessa ragione, ci è sembrato più utile non dare i testi in semplice ordine cronologico, sul filo di un’occasionalità senza più, ma di organizzarli attorno ad alcuni assi e filoni e solo all’interno di questi seguire la cronologia. Il modello è quello offerto dal bel volume antologico, curato da Michel Ciment e Louis Seguin: Roger Tailleur Viv(r)e le cinéma, Institut Limière/Actes Sud, 1997; ma le scelte sono diverse. Per un motivo semplice: che i testi tra i due libri coincidono solo in parte, diciamo per una metà, l’antologia francese raccogliendo una parte consistente da altri fonti, e il nostro libro aggiungendo decine di testi pubblicati su Positif che là non erano contenuti. Come in ogni suddivisione, c’è qualcosa di arbitrario, ma abbiamo preferito organizzare i testi di Tailleur attorno a filoni sufficientemente ampi, sufficientemente generali, ma in grado di rifletterne “i gusti e gli orientamenti”. Così ci è parso giusto iniziare con l’articolo in morte di Gary Cooper perché univa autobiografia e analisi del proprio rapporto con un mondo, l’America, e la sua capacità unica di lavorare sui miti di cui una grande figura di attore è portatrice. Assieme il saggio su Ford e quello su Hawks sono esemplari di una forma critica, così come quelle su I professionisti e su Detective’s Story sono analisi di strepitoso acume che includono in sé la storia di tutto un genere. Il western, poi, è il suo genere per eccellenza, lui che i generi ha saputo analizzarli come nessun altro nel loro aspetto di lavoro collettivo, nella loro dialettica tra normatività e innovazione. Americana è un lungo viaggio attraverso un vero continente, in cui si può forse ritrovare, scandita dal succedersi dei film, una vera e propria storia dell’evoluzione di un altro genere, il noir, dal Mistero del falco ai figli di Huston e Hammett, agli ultimi un po’ degeneri esemplari. E non va trascurato il suo gusto per la commedia, musicale e washingtoniana essa fosse, di Tashlin o Minnelli si tratti. Francia e Italia, il proprio paese e quello d’elezione (quello in cui sostiene che ora si trovi Roger lo scrittore e amico, e ex critico di Positif, Frédéric Vitoux: Il me semble désormais que Roger est en Italie, Actes Sud, 1986), gli forniscono l’occasione per alcuni lunghi, memorabili saggi su Becker e sulla Varda, su Antonioni e su Bertolucci; gli sguardi insoliti da altrove sono indicativi di un’attenzione al nuovo che negli anni Sessanta nasceva in Europa, e i testi sui film di Fellini, Bergman e Bresson incrociano occasionalmente Grandi Maestri, di cui, com’è pure per Buñuel o Welles o Kazan, ha più a lungo trattato in altre sedi (vedi il secondo volume, in preparazione). Le nostre non vogliono essere altro che ipotesi di lettura di un’opera di straordinaria fecondità e ricchezza al cui interno ognuno può ritagliarsi i propri percorsi privilegiati.
La Phorma. Pickpocket di Robert Bresson di Roger Tailleur C’è la realtà e c’è l’arte (lo scherzo, terzo concetto, per ora non mi interessa), il mondo e il cinema. Il secondo deve riprodurre il primo, o essere soltanto atto creativo? Ovvero, cavilli senza fine su un problema mal posto. Il cinema deve creare a partire da una riproduzione imposta da quella macchina stupida e magnifica che è la cinepresa. Di questa tappa necessaria che è la “riproduzione” la pittura ha messo tanto tempo a disfarsene; la 7a arte, finché userà la vecchia camera dei fratelli Lumière, anche se sensibilmente migliorata, non potrà mai evitarla. E Robert Bresson meno di altri, visto che non è né cartoonist, né autore radiofonico, né animatore di marionette. Positif, n. 33, aprile 1960
|
||
