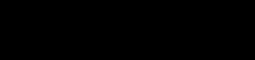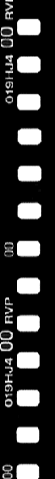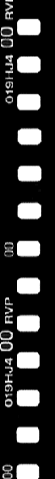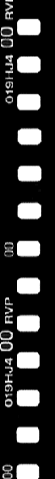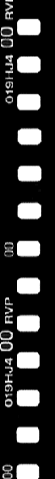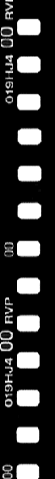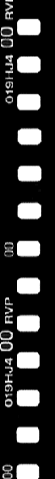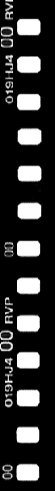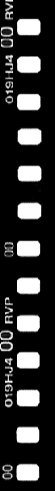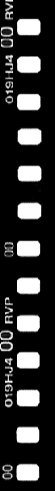PAOLO E VITTORIO, IL MONTAGGIO E IO di Roberto Perpignani È stato molto bello, sin da giovanissimo, “appartenere” per tutta una lunga stagione ad un cinema creativo, di ricerca, d’autore, ovvero, come era spesso definito, intellettuale (epiteto che rimaneva addosso anche alle persone, collaboratori compresi). E suonava come una condizione, o una pretesa, da legittimare con i risultati, che chiunque vi fosse coinvolto aderisse totalmente, fino all’identificazione, al progetto espressivo dell’opera. Una collaborazione quindi che non era solo professionale, ma che diventava una scelta e una condivisione. Questo cinema, che a misurarlo oggettivamente è racchiuso in un arco di tempo definito, è stato il crogiolo catalizzatore di energie creative irripetibili e ha prodotto un notevole numero di opere che vengono citate come radicali per eccellenza. È di questo Cinema che fanno parte da protagonisti Paolo e Vittorio Taviani.
Nel ’68, quando è iniziata la mia collaborazione con loro, avevo già avuto alcune esperienze importanti. L’apprendistato con Orson Welles, i film realizzati con Bernardo Bertolucci, con Marco Bellocchio, Gianni Amico, Roberto Faenza, Salvatore Samperi, tutti coetanei, ma anche le collaborazioni con Alberto Lattuada e Mauro Bolognini che, forse per motivi generazionali, sebbene di grande fascino, avvertivo però meno simbiotiche. È dunque in quel clima che ha avuto inizio la mia “fortunata” collaborazione con coloro con i quali si è maggiormente identificata la mia storia di montatore e di cineasta.
Il mio primo incontro con Paolo e Vittorio non sembrava avere l’aria di un avvenimento destinato a rimanere memorabile. Mi trovavo a montare la “presentazione” del loro terzo film, I sovversivi, a causa del fatto che Franco, loro fratello più giovane, che aveva realizzato con loro il montaggio del film, non aveva modo di occuparsene. Ricordo che il film, condivisibile nel tema e dinamico nelle idee e nella forma, mi era piaciuto moltissimo e sentivo che questo rendeva più facile il mio compito; e l’osservazione non è priva di significato visto che non sono mai stato eccellente nel montaggio dei “trailers”. Ma non molto tempo dopo fui chiamato per un incontro in produzione nel corso del quale mi proposero di montare il loro film successivo, Sotto il segno dello Scorpione, e mi consegnarono la sceneggiatura del film. Sappiamo che la memoria non è oggettiva e quindi il ricordo è in verità una ricostruzione di emozioni. Avevo davanti a me non esattamente dei coetanei, come mi era accaduto il più delle volte in quegli anni, ma allo stesso tempo erano molto aperti e cordiali, sebbene emanassero, insieme alla figura del loro produttore, Giuliani, un imbarazzante senso di rigore. Ricordavano piuttosto l’immagine tradizionale dei “fratelli maggiori”.
Leggendo la sceneggiatura avevo avuto la netta sensazione di vedere il film passare sotto i miei occhi. Era una sceneggiatura che procedeva per immagini, nella quale si potevano già riconoscere con chiarezza tutti i caratteri stilistici, comprese le indicazioni di montaggio che prefiguravano soluzioni percepibili, nette e caratterizzanti. Ricordo che emergevano molte forme prettamente concettuali, era indicato ad esempio l’uso dei “neri”, e se ne ricavava una dinamica visiva che faceva procedere il racconto attraverso la sua forma, attribuendo il posto alle scene, le une dopo le altre, in funzione del senso. Tra le indicazioni operative, le “previsioni” che si potevano leggere nella sceneggiatura, una era diventata per me la controprova emblematica del progetto che si andava a realizzare. Ancora oggi, insegnando, non posso fare a meno di mostrare agli studenti la sequenza nella quale gli Scorpionidi cercano di coinvolgere gli abitanti dell’Isola suggestionandoli con i loro racconti. Nella colonna di sinistra della sceneggiatura, che era scritta all’italiana, si leggeva: “campo totale in cui tutti mangiano e raccontano urlando” – “stesso campo in cui mangiano in silenzio” – “ ancora stessa immagine in cui mangiano e raccontano urlando”. Nulla di verosimile, di naturalistico, di narrativo, non era indicata nessuna transizione, non elementi interpolati tra le immagini, si passava dalle scene urlate ai silenzi assoluti, e di nuovo ritornavano, immediate, le urla. Solo nella colonna di destra, in coincidenza con gli “stacchi”, si leggeva: “cacofonia”. Una descrizione illuminante per una sceneggiatura che era già un’opera creativa. Naturalmente ciò non stava a significare che montare il film sarebbe stata “una paseggiata”, forse tutt’altro. Quella sceneggiatura era la prova di una fantasia audio-visiva che avrebbe trovato la sua realizzazione non in virtù di alcuna mediazione prevedibile tra la parola e l’immagine, sembrava piuttosto un testo che aveva una forza integra da trasferire alle immagini attraverso un procedimento di metamorfosi. Quanta soddisfazione lavorare così. Poi vennero le immagini del “girato” e il film mi sembrò ancora più affascinante. Ed è stato infatti in una condizione di fascino che le scene procedevano giorno dopo giorno trovando con esattezza la loro pulsazione, e non meno attraverso le fasi dell’incontro delle immagini con i suoni, con la musica, con la parola. Mi è accaduto più volte di dire che il risultato mi sembra somigli ad un muro a secco, forte ed essenziale come un muro arcaico, dove le pietre si incastrano naturalmente le une nelle altre, senza amalgama.
Da quell’inizio fino ad oggi, in un rapporto di collaborazione mai interrotto, si sono avvicendati molti film, molti racconti, molte opere, e ogni volta nuovi personaggi e le loro storie, tenuti insieme da rigorose motivazioni. In un certo cinema le ragioni del raccontare stabiliscono dei vincoli precisi, sollecitando ogni volta l’identificazione, l’invenzione, soprattutto lavorando sugli elementi della forma che sono inevitabilmente lo specchio di scelte “ideologiche”. E questo è molto rassicurante, perché è importante non perdere il rapporto con l’ideologia, ovvero con l’emozione che viene dal come si crede nelle cose e nel proprio ruolo.
Al montaggio Paolo e Vittorio lavorano in modo molto convinto, naturale conseguenza dell’impostazione che accompagna tutta la realizzazione del film. Sono e tengono ad essere due personalità distinte che però sanno fondersi perfettamente bilanciandosi in egual misura nella valutazione dei problemi e delle questioni che in ogni fase il film può presentare. Certamente l’essere in due deve facilitare molto la qualità dialettica che è caratteristica ed essenziale nella creazione cinematografica, specie nelle fasi iniziali, dall’idea, al progetto, alla sceneggiatura. Tutti sanno che hanno dovuto far ricorso ad una rigorosa autoregolamentazione, per la quale si alternano alla direzione delle scene durante la fase delle riprese tanto da non far avvertire le differenze, da sembrare fondersi in un’unica personalità.
Ma alla “moviola”, come si diceva “una volta”, le due personalità però si distinguono di nuovo, libere e autonome nell’intepretazione creativa del materiale raccolto. Naturalmente, seguendo il tracciato di un’intesa, il gioco è sempre rigoroso, ma allo stesso tempo è aperto e mobile più di quanto non si potrebbe pensare per un progetto che sia già concepito fino nei dettagli, un progetto che da sempre è anche di montaggio, e quindi di stile. Ma Paolo e Vittorio sanno perfettamente che quello è il momento di una delle più attraenti fasi creative, aperta e suscettibile ai cambiamenti sensibili dell’interpretazione e dell’articolazione elaborativa. Anche se il ruolo del montatore comporta sempre questa mobilità, questa capacità di oltrepassare la schematicità delle previsioni, è molto bello affrontare questo momento con loro con i quali si può essere certi che la mobilità dialettica, aperta in modo esponenziale, è costantemente alla ricerca del livello più alto della realizzazione espressiva. Inserirsi costruttivamente tra due poli dialettici e contribuire al prodursi del fenomeno della sintesi secondo le aspirazioni più ambiziose è effettivamente molto, molto appagante.
Certo che il Cinema di Paolo e Vittorio è cambiato da Sotto il segno dello Scorpione a Luisa Sanfelice, come tutti noi ovviamente. Ma forse è necessario ricordare come tutti i film dei Taviani siano progettualmente diversi, sempre alla ricerca di qualcosa che non sia ancora stato detto.
In trentasei anni di comunanza e di amicizia sono stati veramente molti i momenti in cui il mio ruolo di montatore-collaboratore con Paolo e Vittorio mi ha regalato vertici di autentica soddisfazione e di appagamento, oltre ad un effetto di stabilità e di autorevolezza. Condividendo emotivamente anche le sorti dei film realizzati insieme, i riconoscimenti loro attribuiti non facevano che produrre un senso di autentica gioia, tutt’altro che di riflesso. Ed è stato in una di queste occasioni che Paolo e Vittorio hanno voluto ringraziare i loro collaboratori citandone tutti i nomi. È stato come ricevere anche noi quel premio, ma più che insieme a loro, da loro. Sarei eccessivamente modesto se non ricordassi che uno dei riconoscimenti di cui vado più orgoglioso, un David di Donatello, mi è stato dato proprio per il montaggio di uno dei loro film più riusciti e più emozionanti, La notte di San Lorenzo.
Mi viene da ricordare i nomi dei personaggi dei loro film come appartenenti ad una storia meta-reale di cui faccio parte anch’io e che mi appartiene, come una sequenza di affetti. Li potrei citare tutti, con minore drammaticità di come Giulio in San Michele aveva un gallo pronuncia i nomi dei suoi “compagni”, ma con la stessa convinzione ed emozione.
CON LA MOVIOLA IN TESTA
di Lorenzo Pellizzari
Un grande montatore (che io, pur non essendo esterofilo, preferisco chiamare editor, e poi lo spiego) qual è Roberto Perpignani, è spesso il primo critico di un film: nel senso che esprime, giudica e dispone (se glielo lasciano fare) e in più determina la forma definitiva di un’opera cinematografica (o di un semplice prodotto filmico).
Se un film nasce da un soggetto-sceneggiatura, spesso modificato o disatteso in fase di riprese con conseguenze frustranti per gli interessati, se poi procede grazie a scenografi-arredatori e a costumisti-stilisti, se successivamente trova in direttori della fotografia-datori di luci una propria immagine, finisce sicuramente con il montaggio che - nel bene o nel male - è il vero final cut. In mezzo sta tutto il resto, regia compresa. Senza nulla togliere a chi sta sopra (il primo è stato Frank Capra, cfr. la sua autobiografia) o sotto il titolo quel magico intervento che una volta si svolgeva nella buia e scomoda saletta della moviola e che oggi è molto più tecnologico mi appare determinante.
Parlo pro domo mea, avendo svolto in ambito librario il compito di editor (ecco il richiamo) per oltre trent’anni. Ci sono gli editori (o c’erano una volta, con tanto di nome e cognome: Arnoldo Mondadori, Angelo Rizzoli, Valentino Bompiani, Leo Longanesi, Livio Garzanti) e le case editrici (oggi consolidate in gruppi, ove le singole sigle non hanno più senso, è un po’ come leggere Nestlé e pensare a Motta e ad Alemagna, e non parliamo di Invernizzi, Locatelli, Galbani per uno cui piacciono i formaggi). Ma ci sono appunto gli editor, spesso ignoti funzionari che - oltre a dare qualche dritta nella scelta dei titoli - appena li hanno per le mani se ne impossessano, li rivoltano come un calzino, li ristrutturano, qualche volta li riscrivono e appunto li «montano» sperando in un bell’esito finale (di cui mai goderanno i benefici, se non nella propria memoria).
Ecco, il montatore cinematografico io me lo immagino così. In fieri - come accennato - un critico, che non può ammettere di esserlo; in prosieguo un tecnico che cerca di capire che cosa è chiamato professionalmente a fare; in ultima analisi - se gli va bene - un creativo che offre la visione finale. Ecco io Perpignani - brevemente conosciuto molti anni fa a Fiesole, nel corso di un imbarazzante omaggio ai fratelli Taviani e del quale apprezzai la non necessaria modestia (oddio, in quella occasione figurava come modesto interlocutore persino il maestro Nicola Piovani) - me lo immagino, appunto, così.
Senza averli mai analizzati a fondo di montatori o editor italiani ne conosco tanti (mischiando nomi noti a nomi più sfuggenti, e scusandomi per possibili omissioni): da Eraldo da Roma a Mario Serandrei, da Nino Baragli a Franco Fraticelli, da Ruggero Mastroianni a Kim Arcalli, dal mitico Leo Catozzo a Otello Colangeli, da Sergio Montanari ad Alberto Gallitti, da Raimondo Silvi ad Alberto Crociani, da Jolanda Benvenuti ad Antonietta Zita, Gabriella Cristiani, Tatiana Casini Morigi (le donne nel settore hanno avuto e hanno un grande ruolo, e non solo perché - dicono - sono più pazienti), da Enzo Meniconi a Ugo De Rossi, dall’anomalo Silvano Agosti al ben più giovane Jacopo Quadri; nomi e garanzie per una serie infinita di film italiani dagli anni ’50 ai tempi nostri. Appaiono spesso soltanto nei titoli di coda, quando il pubblico ormai si alza dalle sedie e parlano soltanto a pochi fedelissimi. Ma è come un sussulto: ho capito, abbiamo capito, perché il film, che magari non mi ha, non ci ha, convinto del tutto, eppure funziona.
A differenza di alcuni suoi predecessori o colleghi Roberto Perpignani è uno che medita sulla propria professione e si interroga. Il lungo saggio (qui riportato) apparso nel 2001 nel V volume della Storia del cinema mondiale curata da Gian Piero Brunetta per Einaudi è la dimostrazione di un percorso ma anche di una proposta: una sorta di summa del suo intendere. Nella scarsa bibliografia sull’argomento (soprattutto da parte degli addetti ai lavori) questo prezioso testo, che è laicamente non autobiografico (a differenza, per esempio, di quanto conduce nei propri confronti un direttore della fotografia egregio quale Vittorio Storaro), contiene almeno alcune affermazioni o considerazioni che è meglio qui ribadire: «Se il regista deve essere un narratore, il montatore lo diventa ogni volta per adesione al progetto e contribuendo in modo determinante all’adesione alla scansione del diagramma emotivo. [...] Nel dire che il montatore professionista deve essere come un camaleonte si intende che il passare da un film all’altro, da un regista a un altro, richiede grandi capacità di adattamento riducendo al minimo gli stilemi schematici o ripetitivi. [...] Se il montaggio è veramente salutare, come il cinema stesso, all’uomo, è un questione ancora non risolta: i rischi presi possono essere sempre e comunque risultare involontariamente contraddittori rispetto alle intenzioni».
Spulciando nella filmografia di Perpignani colpiscono a caso (cioè sulla base del ricordo e delle emozioni dello «spettatore critico») alcuni titoli, che voglio qui ricordare scegliendoli al di là dei suoi registi di riferimento, prima Bernardo Bertolucci e poi i fratelli Taviani. Li precede un nome di ben maggior rilievo, Orson Welles, per cui nel corso del 1962 egli cura la mirabile serie Nella terra di Don Quijote e l’ancor più mirabile Il processo. Ma a me piacciono, e li cito in ordine alfabetico per regista, i suoi contributi a La Cina è vicina e a Salto nel vuoto di Marco Bellocchio, a La torta in cielo di Lino Del Fra, a Tre nel mille di Franco Indovina, a Quant’è bello lu murire acciso di Ennio Lorenzini, a Sogni d’oro di Nanni Moretti, a Corbari e Uomini e no di Valentino Orsini, a Il caso Raoul di Maurizio Ponzi, a Vite da ballatoio di Daniele Segre, a Bronte, cronaca di una massacro di Florestano Vancini, a La donna della luna di Vito Zagarrio, film quasi tutti che più sfigati di così non si può, ma che lo sarebbero stati di più senza il suo contributo. Per quanto riguarda i registi stranieri da lui assistiti mi sono sempre chiesto come sia riuscito a trasformare in un piccolo capolavoro (oso affermarlo) Il postino di Michael Radford e come sia riuscito a gestire (piani sequenza compresi) Vizi privati, pubbliche virtù di Miklós Jancsó.
Perché «con la moviola in testa»? Perché si ha l’impressione che Perpignani il cinema lo abbia dentro di sé, capace di accostare immagini disparate, di assemblarle e di contrappuntarle persino in contrasto con la volontà degli altri autori. Spero che sia vero, o almeno - direbbe Pirandello - così pare.
P.S. Ho tenuto conto anche dei seguenti testi che hanno funzionato come guida: Stefano Masi, Nel buio della moviola, Lanterna Magica, L’Aquila, s.d. [ma 1986]; Fabrizio Borin e Roberto Ellero (a cura di), Il montaggio, «Circuito cinema» n. 29, maggio 1998 (con una splendida copertina, dove il corpulento e gigantesco Welles de Il processo pare dominare l’esile e minuscolo Perpignani, ma gli sguardi dei due stanno quasi a indicare il contrario); Diego Cassani, Manuale del montaggio, Utet, Torino, 2000.
|